Analisi musicale e semiologica
L'offertorio gregoriano
"Vir erat in terra"
(prima parte)
di Massimo Bisson
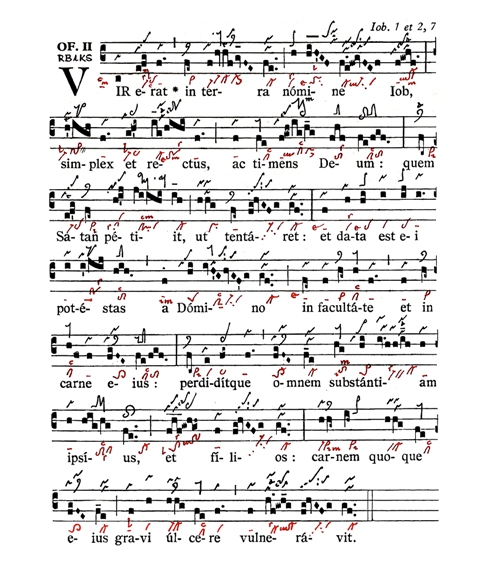
Si tratta dell'antifona per l'offertorio
della 21ª domenica dopo Pentecoste. Il testo è tratto liberamente dal
capitolo 1 del libro di Giobbe: "C'era un uomo nella terra (di Hus) di
nome Giobbe, semplice, retto e timorato di Dio: Satana domandò a Dio di
poterlo tentare e gli fu dato dal Signore il potere (di danneggiarlo) nelle
sue ricchezze e nel suo corpo. Persa ogni sua sostanza e tutti i suoi figli,
colpì anche la sua carne con orribili piaghe". Il testo è presente in
tutti i più antichi graduali a noi pervenuti, il più vetusto dei quali risale
all'800 circa. I segni paleografici della famiglia metense sono tratti dal
foglio 161 del codice 239 di Laon (post 930); quelli sangallesi, invece, dal
foglio 337 del codice 121 di Einsiedeln (inizio del sec. XI).
La prima semifrase ("Vir erat in terra")
comincia con una formula d'intonazione (mi-sol-la-si-la) che si
estende per le prime tre sillabe mediante un neuma monosonico su
"Vir", sul quale il notatore di San Gallo (SG) aggiunge un celeriter
mediocriter, a significare che l'incipit del brano va considerato in modo
scorrevole (non ci si deve quindi appoggiare troppo sul monosillabo
iniziale). Sullo scandicus successivo, entrambe le grafie antiche
mettono in evidenza la prima nota sol; in SG, in particolare, troviamo
anche una serie di lettere aggiuntive: un sursum mediocriter sulla virga
episemata (ciò specifica l'intervallo relativamente ampio rispetto alla
nota del neuma precedente), un levate sulla seconda nota (che precisa
l'intervallo in salita rispetto al sol precedente), oltre ad un celeriter
che chiarisce la natura scorrevole della seconda nota del neuma.
L'intonazione si conclude con un tractulus sul la. Una clivis
con liquescenza diminutiva ci porta verso la parola "terra", i cui
neumi sono tutti allungati: in SG, sulla prima sillaba, troviamo un neuma
composto da un pes disgregato (con note episemate) che conduce verso
la corda di recita do; segue un porrectus flexus con
liquescenza aumentativa la quale, nella notazione vaticana (NV), si trasforma
in una nota vera e propria. Leggermente diversa è la tradizione ritmica di
Laon (L): infatti soltanto il secondo la risulta allungato mediante un
tenete; L evidenzia inoltre una diversa consuetudine melodica: infatti
le ultime tre note sembrano corrispondere a do-si-la-(sol), anziché si-la-sol
della NV. Conclude la prima semifrase una clivis episemata sulla
postonica "-ra", con una cadenza intermedia sulla sottotonica sol.
Emerge chiaro fin qui il ruolo strutturale del la, vera corda di
recita di questa prima semifrase; risulta importante anche il ruolo del sol
come importante nota di appoggio. Il do, pur apparendo (almeno in SG)
in contesto ritmico importante, ha ruolo ornamentale all'acuto.
La seconda semifrase ("nomine
Iob") risulta piuttosto elaborata: la prima virga di SG subito
riporta la melodia al do acuto (il sursum sottolinea il salto
rispetto all'ultima nota del neuma precedente), il quale diventa pertanto
nota strutturale. In L, invece, sulla medesima sillaba troviamo un pes
che potrebbe corrispondere all'intervallo la-do. Segue un torculus
subbipunctis che, in SG, risulta essere allungato (il levate
sulla seconda nota del neuma sembra alludere ad un intervallo di terza tra la
prima e la seconda nota, mentre l'equaliter puntualizza il rapporto di
unisono con il do della sillaba che precede). La postonica finale di
"nomine" è melodicamente ancora più elaborata: troviamo infatti una
clivis seguita da un pes quilismatico subbipunctis resupinus;
SG, attraverso episemi, considera allungate le prime due note oltre alla
quarta; analoga situazione emerge in L, mediante la disgregazione della
clivis in due uncini. Per quanto riguarda invece il pes quilismatico,
il notatore di L non sente il bisogno di fare alcuna specificazione in quanto
la seconda nota del neuma è già strutturalmente importante. Sul monosillabo
"Iob" troviamo uno scandicus quilismatico flesso, le cui
ultime due note sono allungate: in L ciò è reso mediante l'augete, in
SG mediante l'episema; il mediocriter sembra specificare che la
discesa melodica della nota resupina non debba essere eccessiva.
Riassumendo, possiamo rilevare che la sola
sillaba accentata di questa seconda semifrase è resa melodicamente mediante
un neuma monosonico (ad eccezione di L che usa un pes);
tuttavia, dato il notevole allungamento dei neumi nelle sillabe postoniche
successive, occorre appoggiare bene il suono su "no-". Il
monosillabo finale "Iob", proprio per la sua posizione, perde
l'accento in favore della precedente postonica finale "-ne" la
quale, proprio per questa sua funzione, risulta piuttosto elaborata. Anche la
seconda semifrase, come la prima, vede il la come corda di recita
principale; il do, tuttavia, rispetto alla semifrase precedente assume
una rilevanza maggiore, che varrà accentuata ancor più nella seconda frase
successiva.
La prima parte ("simplex et
rectus") si apre ancora una volta sul do, mediante un torculus
resupinus con liquescenza aumentativa (a causa dell'incontro m/p); il levate
sulla prima nota di SG ci avverte circa la salita melodica rispetto alla
cadenza sul la della prima frase; la postonica risolve con un semplice
tractulus. Subito dopo si ritorna verso l'acuto mediante uno scandicus
con liquescenza diminutiva, in cui la prima nota (sorprendentemente un si)
è messa in evidenza tramite una virga episemata con levate; segue
una clivis episemata con torculus resupinus sulla tonica di
"rectus". SG aggiunge un equaliter tra la seconda e la terza
nota: questo potrebbe sollevare dei dubbi circa la corrispondenza melodica
con la NV, tuttavia in questo caso potrebbe indicare un intervallo minore di
un tono. Sono presenti altre due indicazioni melodiche: un mediocriter
sulla penultima nota, che specifica l'intervallo di seconda discendente re-do,
e un sursum. Circa il significato di quest'ultimo, si potrebbe pensare
ad un'indicazione ex parte post, utile ed evidenziare il successivo
salto di quarta verso il la conclusivo della semifrase. Rispetto a SG,
L fa uso del quilisma sulla terza nota della sillaba "re-":
ciò sottolinea ancor più il carattere corsivo del suono do.
Dopo la cadenza mediana sul la alla
fine della semifrase, si riprende con quella successiva "ac timens
Deum":la melodia riprende sulla medesima nota con un tractulus
seguito da clivis corsiva, in cui SG aggiunge un celeriter.
Sulla postonica di "timens" troviamo un neuma composto da scandicus
quilismatico seguito da porrectus flexus: quest'ultimo è concluso
da una dilatazione ritmica a causa dell'incontro di s/d; tuttavia, mentre in
L ciò è ottenuto mediante una semplice liquescenza aumentativa, in SG vediamo
l'utilizzo di pressus minor seguito da stropha di apposizione.
Quest'ultima figurazione neumatica è forse indice di una discrepanza melodica
tra L e NV da un lato e SG dall'altro, cui sembrano corrispondere le note re-do-do-si
anziché re-si-do-si. Nonostante il contesto corsivo di tutta la parola
"timens", è pertanto necessario attuare un leggero trattenuto
ritmico prima di passare alla parola "Deum", che è risolta in
maniera altrettanto scorrevole: il torculus sulla prima sillaba (in
cui il sursum di SG evidenzia l'intervallo di terza la-do-la) è
seguito sulla postonica da un neuma composto da clivis e torculus,
in cui il celeriter di SG avverte circa la scorrevolezza della seconda
nota sol. Il neuma termina sulla nota la, che funge ancora una
volta da cadenza intermedia; il do, per tutta la semifrase, assume
soltanto una connotazione ornamentale.
La terza frase ("quem Satan petiit, ut
tentaret") inizia con una formula di intonazione che elabora lo schema
dell'incipit sulla prima frase: a differenza di quest'ultima, tuttavia, lo
slancio prosegue all'acuto verso il do che, per la prima volta nel
brano, assume carattere di corda di recita per l'intera frase. La discesa al
grave su "quem" necessita di una certo allargamento ritmico,
sottolineato in L con un augete; lo scandicus su
"Satan" richiede un appoggio sul do, evidenziato da tenete
in L e da una virga episemata in SG. Conclude la parola una clivis
con liquescenza diminutiva (richiesta dall'incontro n/p), in cui SG pone
l'indicazione iusum che comporta un piccolo appoggio affinché la nota
liquescente non venga sorvolata. La presenza della liquescenza,
inoltre, permette di risolvere in modo più agevole anche l'intervallo di
quarta verso il do. Arriviamo dunque alla parola "petiit":
sulla prima sillaba, un salicus conduce da do a mi,
nuovo apice melodico, ripreso anche sulla postonica mediana "-ti-"
mediante una clivis con pressus minor resupinus (di cui il celeriter
mediocriter di SG esplica il carattere corsivo). La clivis
episemata sangallese riconduce verso il do, cadenza intermedia; nel
punto corrispondente L utilizza invece un oriscus clivis, la cui resa
ritmica richiede un appoggio sulla prima nota con conseguente allungamento
anche della seconda.
Sulla preposizione "ut", il pressus
maior di SG conduce la melodia verso il grave: così come indicato anche
da L, i due do ripercossi hanno una natura ritmicamente forte, mentre
la terza nota (si) funge soltanto da congiunzione verso il la
della pretonica di "tentaret". Qui SG si limita ad indicare un semplice
tractulus; mentre L, sfruttando un cephalicus, aggiunge una nota
liquescente su sol ripresa anche dalla NV. Sulla sillaba tonica, la
melodia ritorna brevemente alla corda di recita do mediante uno scandicus
subbipunctis resupinus la cui terza nota (il do appunto) è messa
in rilievo mediate episema in SG e allungamento della virga in L.
Anche la clivis conclusiva della frase è costituita da note allungate:
arriviamo infatti ad un'altra cadenza intermedia nuovamente su la.
Tutta la terza frase è concepita come un'unica arcata melodica, che copre la
massima estensione del brano: l'ottava mi-mi.
da
«Una Voce Notiziario», 51-53 ns, 2013-2014, pp. 17-19.
www.unavoceitalia.org